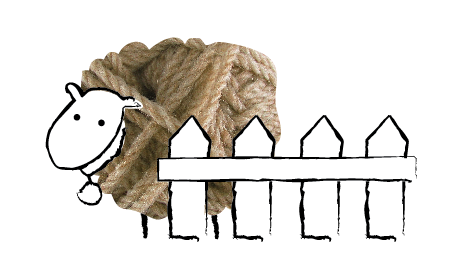Proseguiamo con la conoscenza delle maestre di The Wool School: questa settimana è la volta di Marilena Terzuolo, artigiana e artista del telaio, donna di grande umanità, che ha fatto del suo strumento un mezzo di comunicazione speciale.
Buongiorno, Marilena. Raccontaci i primi passi di artigiana della tessitura a mano: come avviene il primo incontro con il telaio?
Devo confessare che il primo incontro con il telaio è stato decisamente disastroso. A quei tempi (era il 1979) la tessitura a mano era un’arte praticamente sconosciuta. Avevo incontrato una signora tedesca trapiantata in Italia che possedeva un telaietto a tensione per cinture: ricordo la perplessità con cui guardavo quello strano oggetto. Poco dopo mio marito, incuriosito, acquistò un telaio a pettine-liccio senza nessuna nozione sul suo utilizzo, dato che nemmeno il negoziante aveva saputo fornirgli istruzioni. Fu così che a casa cominciò ad armeggiare con un intrico di fili pazzesco e io, spaventata, dissi a me stessa che non avrei mai toccato un telaio. In realtà, poi, lui si stancò di quei grovigli e io mi ci avvicinai per cominciare, piano piano, a domarli. In quel periodo ero senza lavoro, così provai ad aprire una bottega artigiana e iniziai a tessere. L’inizio non fu facile, ma con il passare del tempo e con l’aiuto di tessitori più esperti, diventai più veloce e sicura. Insomma, un inizio molto poco romantico.
Ben presto da artigiana ti trasformi in artista e i tuoi manufatti in opere d’arte: cosa ha portato questo cambiamento? Forse il desiderio di comunicare qualcosa attraverso le proprie creazioni?
All’inizio producevo soprattutto capi d’abbigliamento e complementi d’arredo. Poi nella mia bottega entrò Eugenio Guglielminetti, un artista astigiano che si innamorò dei miei lavori e mi chiese di realizzare alcuni arazzi sui suoi supporti. Io non mi sentivo all’altezza di un tale compito, ma lui insistette. Così mi misi all’opera, facendo del mio meglio. L’impegno profuso diede i suoi frutti e le opere create erano talmente belle che furono esposte in una mostra (la prima di molte) ad Aosta. La collaborazione con Guglielminetti continuò per alcuni anni; poi iniziai a sentire la necessità (si, proprio di necessità si tratta) di realizzare idee e progetti che mi frullavano nella mente. Fu proprio quel “desiderio di comunicare qualcosa”, non attraverso parole che si disperdono nel vento, ma attraverso il mio lavoro che ormai amavo e dal quale mi ero lasciata assorbire, che mi fece fare “il salto” nel mondo dell’arte.
Non necessariamente l’abilità e la capacità manuale sfociano nell’insegnamento: cosa ti ha spinto ad “aprirti” ai corsi?
L’insegnamento è stato quasi un cammino parallelo alla mia attività di tessitrice. Insegnare mi è sempre piaciuto, prima ancora di sedermi al telaio, e i corsi sono stati l’occasione per mettere a frutto il mio amore giovanile per Don Milani e l’universo delle scuole popolari, cercando di trasmettere i miei saperi a chiunque me lo chiedesse. Mi piace il termine “aprirsi ai corsi”, perchè insegnare questo mestiere significa proprio aprirsi, in senso quasi fisico, e lasciare uscire tutto quello che c’è nella propria mente e nel proprio cuore, senza trattenere gelosamente per sé i cosiddetti “segreti del mestiere”. Sono proprio questi segreti, piccole astuzie e accorgimenti apparentemente poco significativi, che fanno la differenza tra il lasciar giacere inutilizzati gli apprendimenti di un corso di tessitura e il riuscire a dar seguito a quello che si è appreso, trasformandolo in un hobby gratificante o addirittura in un lavoro abbastanza redditizio. Molte mie allieve hanno avviato un’attività tutta loro e questo per me è motivo di gioia.
Tra le tue mani e attraverso la tua persona il telaio acquista molteplici valenze: strumento espressivo con i bambini (arteterapia), strumento riabilitativo con persone dalle diverse abilità (ergoterapia), opportunità di lavoro e sostentamento per le donne africane. Come arrivi a pensare tutte queste possibilità?
In realtà queste opportunità arrivano da sole. Semplicemente dico sempre sì quando mi chiedono di insegnare tessitura. Provo fin da subito ad immedesimarmi nell’allievo, cercando le strategie per rendergli piacevole l’apprendimento. L’obiettivo è far si che non sia solo un passatempo, ma che diventi qualcosa di significativo nella sua vita, a seconda della situazione in cui si trova. I bambini sono subito affascinati da questi piccoli telai che uso con loro e i genitori rimangono stupiti che i loro figli riescano a focalizzare l’attenzione su piccoli pezzi di cartone e un po’ di lana colorata, più che su costosissimi giochi elettronici. Con le persone diversamente abili è un lavoro bellissimo: si crea subito amicizia, c’è tanta voglia di fare, e un grande interesse per una nuova attività. Le valenze di questi corsi sono molteplici: mentre le persone fanno progressi nel loro percorso umano, riescono a produrre manufatti che danno soddisfazione e sono vendibili. Proprio come nel caso delle donne eritree.
Il tuo impegno in Africa si svolge attraverso l’associazione “Dodiciceste”: ci racconti di questo progetto?
“Dodiciceste” è la onlus che ho fondato otto anni fa insieme a mio marito. Si tratta di un’organizzazione ecumenica nata tra confessioni cristiane ancora divise ma con un forte desiderio di unità. Crediamo che una delle strade per realizzare oggi questa unione sia proprio quella di portare, tutti insieme, solidarietà e giustizia là dove la povertà è troppo scandalosa. Anche in questo caso è stata la tessitura a mano a offrire un’opportunità. Un’associazione mi chiese di andare a fare formazione nella scuola di tessitura delle suore cappuccine in Eritrea, con l’obiettivo di portare all’autonomia almeno due o tre donne. Devo confessare che in quella circostanza non dissi subito sì, perché l’idea mi spaventava, ma dopo due o tre anni di insistenze mi decisi a partire senza sapere bene cosa aspettarmi. Per farla breve, ora ci sono nove gruppi di donne che lavorano autonomamente in tre villaggi dell’Eritrea per un totale di circa cento persone, più una scuola di tessitura ad Asmara e una cooperativa di quaranta ragazzi sordi a Keren. Più di tante parole, mi sembra una bella testimonianza di collaborazione tra confessioni diverse, impegnate insieme per i fratelli più sfortunati. Ecco spiegato il nome “Dodiciceste”: il vero miracolo che ha fatto Gesù nella moltiplicazione dei pani e dei pesci è stato quello di convincere qualcuno a distribuire quello che aveva, e da quella condivisione sono addirittura avanzate dodici ceste.
Cosa ricevi dall’incontro con le persone a cui sveli l’arte dell’intreccio?
Questa è una domanda preziosa. Dai miei allievi ricevo tutto, anche se il termine “allievi” non rende giustizia alla relazione che si crea nel gruppo. Quando insegno non ci sono allievi e maestra, ma persone che dal loro incontrarsi attorno a un telaio si scambiano saperi, e soprattutto si mettono in relazione tra loro. Crescono insieme l’abilità nel tessere stoffe, ma anche l’abilità nel tessere rapporti significativi: si lavora in coppia nel preparare l’ordito e questo momento iniziale collaborativo non si perde più, e si rafforza andando avanti. Un altro regalo che ricevo nell’insegnare tessitura è il fatto di imparare a tessere: sembra incredibile ma è così. Le difficoltà incontrate dagli allievi mi hanno stimolata a trovare soluzioni agli ostacoli che via via si presentavano loro, spronandomi a cercare espedienti magari poco ortodossi secondo i canoni della tessitura, ma efficaci al fine di ottenere un tessuto ben fatto. Per questo dico che non ci sono allievi e insegnanti, ma solo persone che tessono insieme.
I tuoi ultimi due progetti, ossia il libro Sculture di tessuto. Percorsi tra arte, artigianato e spiritualità e la mostra al Santuario di Oropa dal titolo Per sora nostra madre terra, contengono entrambi un forte richiamo verso l’Alto. Si può dire che attraverso il telaio si dispieghi una forma di meditazione o di preghiera?
Sì, certamente, per me è stato così. Mi ritengo fortunata perché ho potuto scegliere di vivere tra i boschi, nel silenzio di una casa piccolissima e povera ma immersa nel verde. A questo si aggiunga la mia frequentazione giovanile di gruppi parrocchiali dove mi è stato insegnato il piacere di conoscere e approfondire la Parola di Dio contenuta nella Bibbia. Sedersi al telaio può significare raccogliere i propri pensieri senza interrompere l’operosità delle mani e questo è preghiera.
Cosa proponi nei due corsi che terrai per The Wool School?
Ho deciso di proporre per entrambi i corsi l’apprendimento della tessitura a mano su telaio a pettine-liccio, che è il modello più semplice. Impareremo innanzitutto come si prepara per bene un ordito, perché su un ordito ben fatto è poi facile tessere qualsiasi cosa, dal tappeto pesante alla tendina leggerissima. Ma noi siamo molto ambiziosi e quindi su questo ordito ben teso cominceremo subito a tessere arazzi, attraverso l’apprendimento di tecniche differenti. Ogni allievo, al termine del corso, porterà a casa il risultato delle sue prime fatiche tessili e sarà in grado di utilizzare come meglio crede le tecniche apprese: potrà fare le sciarpa per i regali di Natale o lanciarsi in avventurosi impieghi dei materiali più disparati per creare arazzi unici e irripetibili. Se poi qualcuno è senza lavoro sarà in grado anche di iniziare una piccola produzione per la vendita, riservandosi in futuro di approfondire altre tecniche e l’utilizzo di altri telai.
L’intreccio si presta a molteplici metafore e significati. C’è un messaggio che ti piacerebbe “far passare” tra le trame del corso?
È un bellissimo gioco quello della ricerca di metafore e significati attorno alla tessitura e agli intrecci. Mi sta a cuore soprattutto quello del tessere relazioni tra persone diverse tra loro che prima non si conoscevano e che, nodo dopo nodo, imparano a conoscersi e a stare bene tra loro. Insomma, trame di pace, per una convivenza pacifica tra le persone.
Per concludere, un’ultima domanda: c’è un libro che ti è rimasto nel cuore e che ci consiglieresti?
Considero i libri miei compagni di viaggio, veri e propri amici. Tra i tanti che adoro ce n’è uno in particolare che porto nel cuore ed è Diario 1941-1943 di Etty Hillesum, ragazza ebrea di ventisette anni che affronta i campi di concentramento e la morte nel lager di Auschwitz con uno straordinario senso di responsabilità, restando fedele al suo popolo, al bello e al buono della vita. Etty è una giovane donna di Amsterdam, colta e passionale, che vive le sue storie d’amore e i suoi interrogativi spirituali nel clima d’odio del nazismo. Sceglie di non sfuggire alla propria sorte ma di reagire all’orrore e alla violenza rimanendo “un cuore pensante” anche nelle baracche dei lager e riuscendo a respingere fino all’ultimo momento ogni atomo di odio, perché renderebbe il mondo ancora più “inospitale”. Un libro da tenere a portata di mano nei momenti di gioia e in quelli di sofferenza, per ricordarci sempre, come dice lei, che “la vita è bella”.