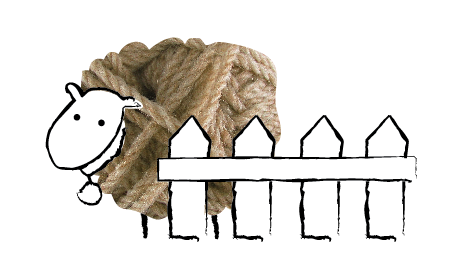Riceviamo e con piacere pubblichiamo la mail di Chiara, lettrice di The Wool Box.
Dopo aver visitato il vostro sito, una certa esitazione e vari ripensamenti, ho deciso finalmente di scrivervi. Non si tratta di un preambolo a un curriculum vitae, un lavoro ce l’ho, e non sto neppure per raccontare la storia della mia vita. Piuttosto è la storia di un percorso che mi ha portato di recente a Miagliano.
Amo gli animali – ho un contatto costante soprattutto con cani e gatti – e lavoro a maglia con entusiasmo, anche se non ho molto tempo libero per realizzare i miei progetti. I grossi animali sono da sempre un’altra passione, anche se non ho mai potuto prendere in considerazione seriamente la possibilità avere una bovina Valdostana castana da compagnia, o una pecora Biellese come tosaerba ecologico per il praticello davanti a casa.
Negli ultimi tempi, anche leggendo dello sfruttamento intensivo delle pecore Merino in Australia e Nuova Zelanda e della miseranda fine a cui sono avviate a fine carriera, mi sono posta delle domande e ho ripensato seriamente ai grossi animali… ma in che veste? Come potenziale allevatore? Non ci credo neppure per un attimo. Ho un grosso limite quando si parla di bestie. Le mie avrebbero tutte un nome, ne osserverei la diversa personalità, le guarderei crescere, mi legherei affettivamente tanto da non poterle “usare” economicamente. Ma una zootecnia “fiabesca” non è né reale né economicamente produttiva.
I bovini sono animali bellissimi, ma poi? Allevarli per la carne, per il latte? So che non ne sarei capace. Crescerli solo per il puro piacere di vederli vivere richiede finanze che non possiedo. E allora capre e pecore… qui forse uno spiraglio c’è. Più piccole, meno impegnative, meno costose da mantenere. E allevarle per vederle vivere e per produrre lana non comporta sofferenza per nessuno.
Tutti però provano a dissuadermi. Mi assicurano che allevare degli ovini per la lana è assolutamente antieconomico. Sui testi di agraria e sui libri che trattano di razze ovine la lana è sempre indicata come uno scarto senza valore. Perché?, mi chiedo. Quanti capi di vestiario in lana ha in casa ognuno di noi? Guanti, sciarpe, maglie, tappeti, tessuti d’arredamento… Da dove vengono tutti questi oggetti più o meno costosi fatti con uno “scarto senza valore”? Il colpo finale viene da un libretto sull’allevamento della pecora. In particolare mi colpisce un capitolo intitolato Lana, un male necessario.
E poi produrre lana per impedire che scompaiano razze storiche locali, per contribuire a mantenere concretamente la biodiversità, per fare qualcosa che si opponga all’appiattimento e alla distruzione delle piccole realtà artigiane locali, per mantenere un legame con la natura e conservare il territorio e, non ultimo (almeno per me), per non dover pensare di vendere o macellare i propri animali ha un senso, oppure sono solo fantasie senza fondamento di un sognatore che vorrebbe, ma che non riesce ad ancorare una sua visione utopica del rapporto con gli animali a una realtà che possa essere anche economica? È davvero inconciliabile il mio sentire con la possibilità di guadagno? Sembra proprio di sì.
Sono a un punto morto, poi per caso incontro le parole “Biella The Wool Company”, leggo della mostra Wools of Europe… la visito e si riaccende l’entusiasmo. Grazie! Toccare con mano che qualcuno riesce ad allevare un suo gregge, creare con la sua lana degli oggetti e vendere un prodotto finito artigianale con un alto valore aggiunto è stata una scoperta inaspettata.
Così, in senso proprio e in senso figurato ora accarezzo una nuova idea. Nel frattempo però la pecora Saltasassi è virtualmente estinta e la Savoiarda resiste anche grazie a un “allevatore custode”.
Ma forse un’attività non esclude necessariamente l’altra. Sicuramente non mi impedisce per ora di documentarmi, leggere, studiare, magari partecipare al vostro prossimo corso di filatura, e pensandoci bene mi piacerebbe anche imparare a produrre il feltro. Ho già in mente il progetto di una coperta con un soggetto animale: i vari colori potrebbero essere quelli di lane naturali in toni diversi, come quelli del vello di una pecora Jacob (e vogliamo parlare dell’emozione di essere la felice proprietaria di una pecora anche quadricorna?).
Così, nei ritagli di tempo, lavoro a maglia, mi dedico alle mie creazioni e medito.
Cordialmente
Chiara